
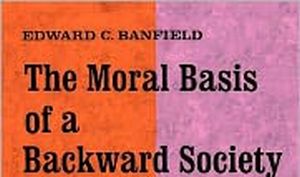
di Isidoro Malvarosa – Era il 1954 quando Edward Banfield si trasferì, con famiglia al seguito, a Chiaromonte, borgo nel cuore della Basilicata. Le conclusioni alle quali arrivò, dopo due di anni di analisi sul campo, non sarebbero state diverse se l’antropologo statunitense si fosse insediato in un qualsivoglia paese della Calabria.
Oggi.
Il teorico del familismo amorale aveva le idee chiare: alcune comunità, specie del Mezzogiorno d’Italia, sarebbero arretrate specialmente per motivi culturali. Alla carenza atavica di infrastrutture e servizi, si accompagnerebbe una visione radicalizzata dei vincoli parentali. Nuclei familiari impermeabili e autoreferenziali, che si chiudono all’esterno, si difendono. Creano microcosmi di autarchia e diffidenza. Puntano a massimizzare i vantaggi materiali di breve termine della famiglia, cito testualmente, supponendo che gli altri si comportino allo stesso modo.
Un tipico abitante di Montegrano, località fittizia inventata da Banfield per dare universalità al suo studio, punta a perseguire gli interessi della propria famiglia e non quelli della comunità cui appartiene. Ripudia l’associazionismo, guarda con sospetto i pubblici ufficiali, punta a trasgredire la legge non appena valuterà possibile farlo senza subirne le conseguenze. È geloso dei beni privati, quanto indifferente verso la cosa pubblica. Appena possibile ruba fioriere, stelle di Natale, panchine e arredi scolastici. Riempie le teche con dentro preziosi reperti archeologici di materiale elettorale e rifiuti, imbratta i muri delle vie del Centro.
Perché “sì fissa si no fai.”
Il confine tra quanto afferma Banfield e quanto aggiunge il sottoscritto è labile e serve per avvalorare i punti di contatto, le similitudini, tra la società lucana di sessant’anni fa e quella calabrese di oggi. Famiglie che gestiscono società, familiari che nominano parenti, famiglie che si associano a famiglie. Che vicendevolmente si proteggono, scambiandosi commesse e favori. Complicità e lavori.
Dalle organizzazioni familiari alle imprese domestiche, raramente negli affari si varca la soglia di casa propria. Ci si associa con non consanguinei. Benevolmente, non ci si fida. Non nelle situazioni che contano. E quindi, lo zio vicepresidente e il cugino a gestire la rimessa dei mezzi aziendali.
Il problema, prima ancora che economico, è sociale. Raramente si agisce per malafede conclamata, è più un atteggiamento naturale. “Tuttu, ma non mi tuccati a famigghia.”
A risentirne sono le relazioni sociali, la crescita umana, la professionalità, la collettività nel suo insieme. Si agisce nell’interesse comune solo per trarne un proprio diretto vantaggio. Se si rivestono posizioni di comando si è facilmente corruttibili. Se si escludono il bocciodromo e il circolo del tre sette, le forme di associazionismo sono latenti. Il voto politico è strettamente clientelare, legato al concetto di favore personale prima che di interesse pubblico. Chi proverà a spendersi per la cosa comune sarà malvisto, accusato di malaffare o, nel migliore dei casi, di doppiogiochismo.
Nella Montegrano degli anni Cinquanta vista da Banfield, l’uomo era prima capofamiglia e dopo cittadino. Otteneva il rispetto dei suoi simili battendosi in difesa della propria stirpe. Il buon esito dei suoi sforzi, il loro riconoscimento pubblico, era dato dalla non-intromissione altrui nella propria sfera d’influenza. Ne viene fuori una società chiusa e diffidente, un’economia che si basa sulla mera sopravvivenza, un potere pubblico giudicato estraneo e ostile. La deriva verso forme di potere autoritario è dietro l’angolo.
Il familismo amorale è oggi considerato da molti autori come un modello rappresentativo della società mediterranea. Pur con le dovute cautele e riserve derivanti da una parte dalla rappresentazione generalizzante che ne consegue, dall’altra considerando la portata rivoluzionaria di un approccio che possiamo definire a tutti gli effetti antropologico. La teoria di Banfield viene, infatti, inquadrata nel filone delle ricerche anglosassoni nell’aria dell’Europa Meridionale, fondamentalmente basate su un vecchio approccio metodologico verso le culture mediterranee. Tuttavia, nonostante le critiche rivolte in questi decenni al sociologo americano, è opera davvero ardua non riscontrare nel suo paradigma delle affinità con la società in cui oggi viviamo.
Se a Montegrano sostituissimo un qualsiasi comune della provincia reggina, se cambiassimo la data di pubblicazione del suo saggio Le basi morali di una società arretrata postdatandola di cinquant’anni, nessuno giudicherebbe la ricerca inappropriata e anacronistica. Oggi come allora le analogie, così come le controversie, sarebbero le stesse. Reggio Calabria (inutile girarci ancora intorno) non è Montegrano, non lo è stata, men che meno lo è adesso. Tutti più interconnessi e collegati, specie negli ultimi dieci anni sono stati fatti passi da gigante. La rivoluzione cibernetica e digitale, e con essa quella dell’informazione che consente a chi scrive di portare a conoscenza questa teoria ad un pubblico vastissimo, è arrivata anche in queste lande. Ciò nonostante, dobbiamo rivolgerci qualche domanda: per scegliere un dipendente ci rivolgiamo all’ufficio di collocamento o chiamiamo nostro cugino? Come socio fondatore di una nostra associazione culturale inseriamo nostra moglie o il postino? E dobbiamo rispondere sinceramente.
